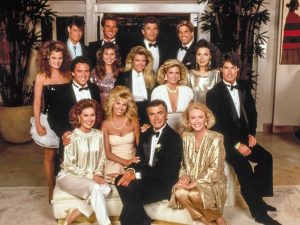Non è una fotografia che scattiamo e mettiamo da parte, immutabile nel tempo. Al contrario, la memoria è qualcosa che si costruisce, che si plasma, e che, in fondo, si impara. Ogni ricordo che portiamo con noi è il risultato di un processo attivo, influenzato da come ce lo raccontiamo, dalle emozioni che proviamo e da ciò che gli altri ci aiutano a ricordare.
Cosa troverai in questo articolo
La memoria non è una registrazione fedele della realtà.
Ma ti sei mai chiesto chi ti ha insegnato e come hai imparato a ricordare?
Pensaci! Come hai costruito la tua memoria? Magari hai ricordi vividi della tua infanzia perché tua madre o tuo padre amavano raccontarti com’eri da piccolo. Oppure, al contrario, certi episodi ti sfuggono perché nessuno te li ha mai narrati o perché le storie di famiglia sono state sostituite dal silenzio. E tu, oggi, come racconti il tuo passato?
Forse non ci hai mai pensato, ma la memoria è una costruzione sociale. Non è qualcosa che nasce perfetta dentro di noi: è un mosaico fatto di parole, emozioni e relazioni. Impariamo a ricordare attraverso il dialogo con gli altri, in particolare con le persone che si prendono cura di noi.
Lev Vygotskij, uno dei più grandi psicologi del XX secolo, ha dedicato la sua vita a esplorare questi temi. Secondo lui, ogni ricordo che conserviamo è il risultato di un processo condiviso.
La memoria non è un archivio statico: è un racconto che impariamo a costruire.
Prova a pensare ai tuoi primi ricordi. Quanto di quello che ricordi è veramente tuo e quanto, invece, ti è stato raccontato da qualcun altro? Forse non ricordi con chiarezza il tuo primo giorno di scuola, ma magari tua madre te lo ha descritto in mille dettagli: il grembiulino, la maestra, il tuo compagno di banco. A furia di sentirlo ripetere, quella scena è diventata tua, come se fossi davvero in grado di riviverla.
Vygotskij ci ha insegnato che è proprio così che funziona. I bambini non ricordano da soli: sono gli adulti, con le loro domande, i racconti e le emozioni che trasmettono, ad aiutarli a costruire la memoria. Ad esempio:
- Un genitore che dice: “Ti ricordi quando siamo andati al parco e hai visto le anatre?” sta insegnando al bambino a selezionare e organizzare i dettagli di quell’episodio.
- Un nonno che racconta una storia di famiglia, legandola a un evento emotivo, aiuta il nipote a radicare quel ricordo nella sua identità.
E… le parole che usiamo non sono neutre: modellano il ricordo, dandogli un significato.
Ogni adulto guida il bambino nella costruzione della memoria in modo diverso. Anche se non ce ne rendiamo conto, il nostro stile di comunicazione lascia un’impronta duratura. Ecco tre stili principali che Vygotskij avrebbe osservato con interesse:
- Lo stile elaborativo
Alcuni adulti amano arricchire i ricordi con dettagli e domande. Dicono cose come:
- “Ti ricordi chi c’era alla festa? Cosa hai fatto con Marta? Ti è piaciuta la torta?”
Questo stile stimola il bambino a rievocare i dettagli e a costruire narrazioni più ricche. Non è un caso che i bambini cresciuti con adulti elaborativi sviluppino memorie autobiografiche vivide e articolate.
Ti riconosci in questo stile? Ti piace approfondire, chiedere e aggiungere dettagli?
- Lo stile ripetitivo
Altri adulti si concentrano su pochi aspetti, ripetendo sempre le stesse domande:
- “Ti sei divertito? Ti sei comportato bene?”
Questo stile è meno stimolante, ma aiuta comunque a fissare un punto chiave del ricordo, come un’emozione o un comportamento specifico.
Sei il tipo di persona che ripete le stesse domande, magari per rassicurarti o per sottolineare un punto?
- Lo stile emotivo
Poi ci sono adulti che danno più importanza alle emozioni che ai dettagli. Chiedono, ad esempio:
- “Ti sei sentito felice quando hai visto le anatre?”
- “Ti sei sentito triste quando Marta è andata via?”
Questo stile insegna al bambino a legare i ricordi alle emozioni, rendendoli più significativi.
Quando racconti un episodio, ti concentri sulle emozioni o sui fatti?
Il ruolo delle emozioni: una memoria che sente e vive
Immagina un genitore che chiede: “Ti ricordi quanto eri felice quel giorno?” o un insegnante che dice: “Hai visto quanto sei stato coraggioso?” Queste domande non solo stimolano il ricordo, ma insegnano anche a riconoscere e dare un nome alle emozioni. Per Vygotskij, questo è fondamentale: i ricordi più vivi sono quelli legati a emozioni intense.
Ma c’è un’altra verità che spesso trascuriamo: anche il nostro stato emotivo attuale influenza il modo in cui ricordiamo. Se oggi sei felice, potresti guardare al passato con occhi più indulgenti; se sei arrabbiato o triste, potresti rivivere i tuoi ricordi in modo più cupo.
E tu, come ti senti quando ripensi al passato? Quali emozioni emergono?
Se la memoria si forma nel dialogo con gli altri, allora non è mai troppo tardi per cambiarla. Proprio come un adulto aiuta un bambino a organizzare i suoi ricordi, un counselor può aiutare una persona a reinterpretare il proprio passato. Attraverso il dialogo, possiamo scoprire nuovi significati, dare una forma diversa ai ricordi dolorosi e costruire una narrazione che ci supporti nel presente.
E tu, come racconti la tua storia?
La prossima volta che ricordi un evento, chiediti:
- Quali parole sto usando per descriverlo?
- Che emozioni sto provando in questo momento?
- Quanto del mio racconto è davvero “mio” e quanto proviene da ciò che altri mi hanno detto?
Ricorda: non siamo mai prigionieri del nostro passato. Ogni volta che raccontiamo una storia, abbiamo l’opportunità di darle un nuovo significato.
Lev Vygotskij ci ha insegnato che la memoria è un dialogo: non solo con gli altri, ma anche con noi stessi.